
11 Apr 10 y el canto de todos
Senza consultare la metà che manca, mi permetto l’abuso di rendere pubblico questo canto forse incompleto, di certo incompiuto, scritto a quattro mani.
Mi disturbava che nessuno sapesse davvero cosa stava accadendo, che non si potesse dire, spiegare, nominare. Credo che questo rappresentasse parte del problema.
Adesso penso sia giunto il momento di raccontare ciò che el astronauta y la bruja sono stati, o hanno immaginato di poter essere, almeno a parole.
sette strofe di un canto a due voci
di Lucha e Sofia
Lo sveglia un cigolio. Violino nasale, un lamento si trascina e raschia pareti troppo sottili, scivola sul pavimento, si asciuga sul materasso.
O lo sveglia un bandoneón, cuscino che vibra d’altrove, stanza scaldata da un soffio inquieto, brancolare del sonno, pianto ubriaco.
Lo sveglia invece un canto, nenia che barcolla rauca, l’arco graffia le corde vocali, il mantice si affanna tra la pancia e il petto.
Nevica sul letto, sulle parole lette e masticate insieme, sulle briciole dell’ultimo pasto dolce e sudato dei corpi. Cadono fiocchi di lettere sfuse, cenere, biglietti, numeri senza più telefono, il vento agita agende ridotte in coriandoli, bianco e nero di giornali. Tra le lenzuola l’odore ha messo radici e unghie, trattiene la frana dallo straripare del caffelatte che ogni volta le serve al risveglio. Quando lei scende in strada, gli rimane accanto una piazza senza mercato, senza vociare di primavera. Neve sporca su cui si riaddormenta male, scosso da una fame fredda che non passa. La luce tra le fessure illumina la sua luna di cartapesta.
Lo sveglia una fanfara che passa.
Lo svegliano cori.
Urla
Botti
Sirene
Carica il grilletto dei nervi il pensiero di lei così piccola tra la folla.
La mattina ha ancora due gambe sole, le sue. Fende l’aria a colpi di tacco, trotta a ritmo, danza in levare.
Le pareti di questa città sono pentagrammi sudati e giallini. Traccia di adolescenza nei disegni sui muri. Ride dei messaggi urlati a colori. Qualche accento sulle vocali ammonisce che non è “di là”, nella città vecchia dove il rosso è diventato mattone ma dove baffi di vernice e colla ricordano anche le sue mani. E’ in un qui che non è il suo. Ride anche di questo; tempo e spazio sono diventati artifici comici per qualche programmatore di videogiochi, nella sua testa. DLIN-DLON. E’ al livello 8, pare. Dieci anni prima sei bambine cercavano un parco per dormire al sicuro, insieme. Ridevano della distanza, non volevano un tetto a intralcio per stelle. Due di loro danzavano per pagare da bere alle altre; una terza passava con un bicchiere in mano. Si faceva a turno. “balla balla ballerina, tutta la notte, fino a mattina…” Qualcosa di simile a una malizia orgogliosa soffia caldo nelle guance e nel cuore.
Il “locutorio” verde e viola ammicca, fino a inghiottirla.
Concerto per tastiera sola. Word. Apri nuovo documento. 1-2-3-le dita minuettano, inizia allegro ma non troppo il sabba del racconto al femminile.
“Brujitas mìas,
siete in ogni angolo del Raval. Una litiga col Chino per il resto sbagliato. Due bruciano i pochi risparmi nell’ago di un tatuatore. Due ci guideranno tutte tra i sentieri di carta della Routard.
Mi incalzate di domande; Giulia è un flauto traverso e indiscreto che sa di rimare senza eco…
Ma scostate i capelli dalle orecchie e fate silenzio…
Dirò solo che mi ha commosso il suono dei suoi occhi in una sera di novembre. Che aveva sale fra le dita, retaggio di porto. Che mi ha avvolto e presa alle spalle; allo sgambetto ho risposto franando sulle sue ginocchia.
Sperava, forse, di non sapermi accordare.
Cadendo sono finita quassù, accanto a Margherita. Coro di barbagianni e raganelle quella sera, al cospetto del camino. Davanti alle sue fauci spalancate piedi a compasso intrecciavano desideri; ogni carezza di punta una promessa d’altrove. Schivando foreste di gomiti ridevamo di noi e della pancia di un bandoneòn, ubriaco e triste di maniera.
Ora mi so capace di canto. Tornerò a casa in una pioggia di note da restituire alla terra.”
Controlla il resto, risponde allo sguardo di mandorla dietro al bancone, sorride.
La banda è lontana. Segue le tracce luminose delle sirene in lontananza.
Gira i rubinetti a caso, entra nella vasca senza badare alla temperatura, rischia un femore sul filo della schiuma vecchia che riprende vita sul fondo. Si aggrappa e strappa la tenda di plastica e pesciolini, maledice ventose e anatroccoli cinesi che non attaccano. La saponetta al miele sfugge impaurita all’impeto. Non ha tempo per la meccanica della decenza, si veste che è ancora acqua gelida, sapone e sudore, indovina i buchi a occhi chiusi, non il verso. L’etichetta gli graffia il collo mentre le gambe già spianano scalini in discesa.
Gomma bruciata. Para lo schiaffo del fumo col maglione sul naso. L’aria del quartiere carica di lacrime, non sa da che parte andare, non ha mai lanciato sassi se non sul pelo dell’acqua. Tre direzioni. Dritto di fronte a lui, appena un isolato, immagina la piazza abbracciare l’invito del bar in cui potrà ancora una volta ripetersi che lui non è ora, lui non è qui.
A destra è un silenzio anomalo, da piombo domenicale, dipinto sulle saracinesche abbassate di fretta, sugli scuri chiusi, picchiare di legno contro legno, sugli occhi a strisce dei gatti d’appartamento, sulla paura in ciabatte e le televisioni che non può vedere ma indovina accese in soggiorno, il volume giusto per farsi ascoltare dalla cucina. E’ martedì, pensa. Non c’è odore di minestra né di sugo. Rimangono, nel letto della strada, i resti di una tromba d’aria, l’anima esplosa e sparsa dei cassonetti, segnaletica non più verticale, bottiglie spezzate, cocci senza padrone. E il suono di passi leggeri in fuga, di stivali pesanti a inseguire. A sinistra è il fuoco. A sinistra i vicoli sono rivoli e torrenti per nascondersi, disperdersi, ritrovarsi alla piazza successiva e ricostruire il muro, riempire le trombe, vuotare i tamburi, gonfiare il coro. A sinistra il solo canto di sirena che non strega, non ammalia ma minaccia sangue in bocca. A sinistra deve essere lei, con la sua lente troppo curiosa. Vene e nervi hanno deciso, la testa non si oppone, barba e capelli in testa al gruppo, segue il resto del corpo. La corsa è senza copione, più il rumore e la puzza si avvicinano, più va smarrendo l’unica traccia utile, il profumo del suo collo appena dietro i lobi.
La battaglia si sposta sempre un po’ più in là, non riesce ancora a raggiungerne il centro, qualcuno esausto e ferito ha mollato la presa e adesso zoppica in senso contrario. Lui che crede di sapere sempre tutto ora non sa proprio nulla, non sa perché, non sa dare un nome alla barricata. L’unico nome che urla è un nome di donna, lo grida negli angoli, nelle orecchie, nei tombini, nello spiffero di un uscio dal quale offre riparo ai fuggiaschi un’anziana signora.
Non la trova. Nemmeno sotto le bombe potrebbe confonderla. Ma non è mai dove crede di poterla collocare, pensa. Ha una mano d’olio, due tacchi imprevedibili. E intanto non si accorge dell’onda anonima che lo cattura, della schiera di volti coperti che lo mangia senza masticare. O forse non si oppone, si lascia risucchiare per condividere anche questo. Quando tace e si rimette sul naso la ragione, il suo vicino di marciapiede sta accendendo una bottiglia, davanti è un muro di scudi. Qualcuno dei mattoni si inginocchia e non prende di mira il cielo. Lacrimogeni.
Prega che i suoi occhi e la sua lente siano già in salvo. Spilli in gola, una tosse violenta stritola i polmoni. Invoca sollievo, soffio dalla sua bocca di strega.
Arriva alla piazza, esule e ospite. L’abbraccia il corpo comune di occhi e gambe. Ci arriva chiedendo permesso e prendendo posizione. Come quando si trovava ai piedi della Lacandona; osservatrice e ospite, pensava. Devo comportarmi bene. Li avrebbe voluti con lei, “gli altri” come nel disegno su stoffa all’ingresso della Strada. Lei, la più piccola, partorita dall’inchiostro di Maya.
Privatizzazione dell’acqua in tutta Europa. Forse è una faccenda che mi riguarda, aveva pensato. Voleva pagare il debito con casa sua. Quando hanno chiuso tv e giornali lei non c’era, troppo impegnata a snobbare la retorica del popolo viola per inseguire a passo di tango la sua strada. Ora, violando frontiere sulle punte, poteva dire la sua lì dove stava, dove voleva.
Il naso un radar sulla circonferenza dei palazzi: lui non c’è. Il primo scoppio le ricorda l’urgenza di altri cuori. Che corrono. Qualcuno è così vicino da diventare pericolo di pance e gomiti da schivare, offrendo le spalle a sua volta. Piroetta e vola, una gamba buttata dopo l’altra. Così per un tempo sospeso. Poi l’odore acido si arrampica sul naso. Poi gli occhi si bagnano, bollenti. Poi ricorda il Carlini e i rivoli intorno, nell’estate maledetta. Con le altre, limoni e acqua in mano, si gridava a tutti “i portoni”, “aprite i portoni, non state al centro della strada!”. Scarta a destra.
Un cancello socchiuso l’aiuta a liberarsi degli stivali. Il cuore un martello sul palato, sputa saliva e si aggrappa all’inferriata. Stringe il pugno, sa che il freddo dovrebbe tenerla sveglia e cosciente.
La telecamera minuscola, stritolata nella sua destra, avrà catturato pochi minuti, prima di diventare appendice pesante di una mano in fuga. Libera la sinistra e guarda l’onda blu coprire l’asfalto di passi sordi.
Non lo ha visto passare. Forse dorme ancora. Poche ore prima si era arreso al sonno, rapito dal respiro comune.
Le era costato fatica liberarsi dalla mezzaluna di braccia per tornare alla mischia del mondo. Tradire la sua pelle di farina e zucchero per inghiottire freddo a manciate.
Socchiude le labbra cercando il sapore morbido del due; la nostalgia è un fiocco rosso in gola.
L’aria è ancora cattiva; torna in sé. La vertigine sulla schiena le ricorda di consegnare la cassetta al media center. Suda e trema.
Muriel è sull’altro lato della strada. Si riconoscono in silenzio e camminano nella stessa direzione.
Riemerge dalla breve apnea d’una fontana. Di chi è quest’acqua adesso, di chi quest’intreccio di atomi in amore? Adesso respira. Adesso che qualcuno l’ha spinto fuori dal recinto concentrico della mattanza. Ha perduto il suo maglione rosso, sente freddo. Nell’acquario degli occhi si disfano ancora banchi di pesci, sullo sfondo fauci aperte di squalo. Eppure credeva di averla vista, coi bordi sfumati dal vetro opaco di lacrime, più alta di tutti, le gambe salde, ferro piantato in mezzo alla corrente. Ha teso una mano ed è partita un’altra carica.
Dal marciapiede accanto alla fontana, un tizio trova posto per un sorriso in mezzo alla faccia gonfia. E lui immagina di guardarsi allo specchio, replica con uno sforzo delle labbra.
“De dónde sos, remera a rayas?”. Mastica un accento che riconosce, la linea del mento indicava la sua maglietta.
“Italiano”, risponde, guardandosi le righe addosso.
“Anche io. Nonno di Genova. Roberto, come lui”. Tende una mano che è un viaggio sull’Atlantico, di andate che eccedono i ritorni. Lui stringe e pensa a questo magnetismo inconsulto del caso che lo strattona sempre verso il medesimo penultimo Sud. Ormai fatica a credere che Argentina sia solo l’espressione di un’equazione senza risultato. Si sente al sicuro, cerca il tabacco in tasca, si siede anche lui e armeggia. Le dita tremano. Adesso sa che è stato Roberto a tirarlo via dalla strada, giù per il vicolo.
“Guardavi in aria. Sembravi un bambino che ha perso la mamma”, ride, italiano fin troppo pulito.
In effetti lui l’onda della carica non l’ha nemmeno avvertita, momentaneamente smarrito, assente. Dice grazie a quest’altro marinaio. Poi tace, guarda avanti, fuma. Pensa ai telefoni spenti l’uno accanto all’altro sulla scrivania. Cancella il gesso sulla lavagna, riscrive un pensiero. Stavolta non è scappato, non è stato più furbo, ha cercato il fuoco. Continua a capo. Nelle sue gambe era lei. Nelle gambe, nelle facce, nelle braccia di ognuno ha visto lei. E stavolta c’era anche lui, inebetito. Impasta coi pugni un sorriso e una rabbia col vestito nuovo. Si era sempre sentito coinvolto. Non ci aveva mai messo il corpo. Ce n’est que son début, forse.
Roberto si riaggiusta sui suoi sandali, gli porge ancora una mano.
“Dove andiamo?”
“A buscar a tu mamá, boludo!”. Ora ridono in due.
Lui si fruga nelle tasche, gli offre una sosta al bar.
Alza la testa, inciampa in ipotesi di stelle. La sua manciata di immagini è al sicuro. Diventeranno coperture o forse punteggiatura di un racconto comune. Il media center alle spalle è come tutti quelli annusati prima: un lenzuolo di fumo a mezz’aria, occhiaia violette qua e là, voci alte che rimbalzano su pareti spoglie. Muriel le ha prestato la sua lingua di lentiggini per dialogare con qualche catalano scontroso. E’ solo il tono, pensa. Sembrano incazzati neri e invece sarà solo questione di diaframma. Trova alibi a ogni corpo collettivo che cerca disperatamente di conquistare. Saluta la complice, incorniciata da trecce come orecchini d’argento, poi si allontana nel fascio di un lampione, piccolo moscerino incollato alla luce.
Cammina e conta il numero di passi. E’ già in riserva, oggi non ne rimangono abbastanza per il Cafè La India, al Raval. Non vorrebbe lasciar passare un’altra sera, le servono soldi o questa specie di esilio finirà prima del tempo per necessità di welfare familiare. Deve trovare un lavoro e vuole trovarlo lì. La India, tana di due fotografe messicane che hanno infagottato un luogo della propria città, del Monstruo, per sentire meno la distanza. La stessa India di Julio Antonio Mella e della sua ultima notte, la stessa di Tina Modotti, ricorda.
Sì, qualche passo le avanza e allora accelera, tequila nelle gambe. “Balas y bailes”, le dicevano nel DF. Quasi corre.
Segna nome e numero di telefono sul foglio bianco e lo riconsegna alle mani laccate di Lupe. Le ciglia sono un diaframma che si chiude, click: quel posto le piace. Saluta le due donne con una specie di supplica negli occhi e torna verso casa. Ora è a rosso-fisso. Procede per inerzia fino a Gracia, non sente neppure il baccano legnoso dei tacchi, non ride al pensiero di topi in fuga al suo passaggio. Prende a calci se stessa fino al primo piano. Ha un unico desiderio: odore di pizza, di vino rosso e poi di culla. Non vuole affrontare la notte di petto. Non vuole decidere di dormire. Vuole l’incanto dello stregone, il tocco di dita che la rapirà dalla veglia.
Percorre il lungo corridoio. Sulla sinistra, dalla fetta di luce, vede per prima la curva della schiena. Lui raccoglie i vetri di una lampada rotta, sparsi per terra…si sono portati un pezzo di piazza su, al primo piano, pensa lei guardando la devastazione del piccolo ambiente e le guance stanche di lui.
La comicità ha un’estetica tenera. Scopa e raccoglitore diventano lo scettro di un re ospite cui rendere omaggio. Lei ha una foglia stritolata fra i capelli; la sfila e la porge in un solenne inchino improvvisato. Lo specchio fra di loro strilla l’uguale disordine dei corpi: per oggi non serve parlare.
Poi è solo il naturale attrarsi di due orbite, la curva armonica di pianeti bagnati nel mare buio dell’universo. Onda su onda, la pelle diventa tela di sabbia per disegni e capriole. Cercano conchiglie e trovano stelle marine. Nuotano insieme nel cotone e giurano di ricordare il suono di un violino nell’oceano.
– Non riusciranno a disinnescarci. In questo prato non entreranno. Ci protegge la saracinesca delle palpebre –
Lei dorme in un gomitolo, lui non può, spalle al muro. La guarda, la immagina occupare tutta intera appena un palmo della sua pancia. Ogni tanto nota le labbra cambiare disegno, curvarsi appena agli angoli, lì dove nascono e muoiono i sorrisi, lì dove vorrebbe ancora sfiorarla. L’accenno di un vagito modifica di centimetri la posizione. Quel tanto che basta perché lui possa baciarle il naso con gli occhi. La stessa chiave che apre il cielo quando la terra non merita. Stessa linea. Stesso pollice di bimbo che segue attento le righe, quando entrambi aprono i libri. E cioè quando lei legge e lui invece non fa altro che riattraversare a vanvera la medesima frase, perde il filo, trova il profilo, cerca di decifrare le storie tra le mani di lei, dal riflesso negli occhi. Geloso. Invidioso di parole altrui che solleticano il palato delle sue sinapsi. Felice della sua fame. Felice di poterla vedere mangiare.
Spezza due quadratini sul comodino sovraffollato, stavolta fa attenzione a non sgomitare via l’abat-jour. Lascia che la cioccolata si sciolga senza rumore. Nell’era della riproducibilità tecnica questa tenerezza orizzontale non sembra replicabile. Collezione privata, invisibile, non trasmissibile. Ogni battere di ciglia una fotografia senza negativo, né byte né ritocco. Donata al museo della memoria.
Lo ha ritrovato lei, lo ha trovato qui, in preda al nervosismo di ogni attesa consumata in gesti inquieti e disordinati e silenziosi delle mani. Non c’era altro posto, come per ciò che si smarrisce negli angoli più probabili, gli occhiali nascosti sulla testa. Lo ha capito quando Roberto gli ha sventolato sotto gli occhi un indice a segnalare la penna sul tavolo, dopo averlo guardato ravanare tra brandelli di fazzoletti nelle tasche, ancora divertito dalla sua goffaggine. Allora ha scritto il suo numero su un tovagliolo, ha riempito il tavolo di spicci, è schizzato via come chi sospetta di aver dimenticato il gas aperto, un saluto appeso alla porta spinta a schiaffo. Eppure indossava una calma nuova, certo di non dover temere il peggio, di non dover contare un’assenza.
Guarda fuori. Il vento scende a rimbalzare, prigioniero tra le pareti del cortile. Unico movimento nel tempo adesso immobile. Non esiste altra casa. Per lui che non riesce più a riconoscersi nelle sue strade, ha rifiutato di essere ingoiato dalle paludi della cittadinanza, è stato privato dei tramonti sull’isola. Non è fuga, è un esilio forzato, mura tra le quali nessuno nega asilo ai sogni, dove speranza non è una parola pericolosamente vuota. Non è una rinuncia, non è un ripiego. Lei è l’unico luogo in cui soffia una carezza sulle tempie. Fissa lo sguardo sulla parete est, la attraversa per miglia sul mare. Questa è un’astronave, una bolla d’aria infrangibile. La trascina per mano, a riprendersi la parola amore, a strapparla a morsi alla propaganda. Questa è una nuova fondazione. Si lascia guidare dai passi esperti di lei per le strade di Roma, a cancellare coltelli e orologi neri dai muri. Questa è una cospirazione, dice ormai a mezza voce. Il corpo scarica sul letto la tensione di un sussulto. Teme di averla svegliata. Trova i suoi occhi pazienti, aperti nella valle di lana e cotone. La mano sulla maglietta lo tira giù e indugia sulla pancia, accompagna il ritmo del respiro verso la quiete. Chiude gli occhi. Questa stanza non conosce muffa. Restituisce un senso ai pugni stretti, mentre scioglie il nodo delle dita. Questa stanza si muove. Un profumo di gelsomini lo addormenta. E un sussurro che dice torneremo.
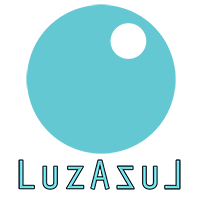
Eros
Posted at 20:30h, 11 AprileHo rispetto e trasporto per la poesia, per l’arte, per l’ambizione verticale che chiamiamo amore senza sapere davvero come si compia. Io e lei ci siamo trovati nel nostro momento peggiore, il più difficile, quando non hai più equilibrio e un miracolo avviene sotto i tuoi occhi, qualcuno ti sta guardando e sta guardando proprio te, e non passano su di te gli occhi ma entrano dentro arrivando fino in fondo. Ecco come è avvenuto.
Non c’è ostacolo che io non voglia oltrepassare o tempesta che non si lasci bucare dal suo odore quando si sveglia. Non c’è mattina che quel caffè bevuto insieme non abbia il sapore della nostalgia di tutti i sorsi futuri. Non una sua parola che si disperda senza aver lacerato i miei pensieri. La perfezione non c’è ma con le mani io mi sporco dello sporco del mondo e con quello racconto il mio nero. Non c’è sera che non si costruisca nella mia mente un’architettura di versi o l’elegia di un racconto. Lei è la mia ambizione di riuscire ad essere vivo. Mi faccio grande, vivo rinasco e muoio, e come una commedia senza dio annetto inferno paradiso e purgatorio. Sto compiendo tutto il viaggio senza ritorno. Sto aprendo tutte le porte perché il mio senso non faccia prigionieri. Ho costruito forme di libertà da regalare anche a te, per non privarti il mio egoismo di un sogno bellissimo, ma le abbiamo distrutte, annichilite, disinnescate per un legame invisibile che è più forte delle parole, che non ha bisogno di sguardi, che è muto come il tempo e come il tempo dura. Ho un vizio che mi porterà a morire, un vizio d’eternità che mi accompagna da quando ho smesso di essere idea e mi sono fatto carne. Ho vagato, ho pianto, ho benedetto la solitudine, ho sbagliato la mia strada, mi sono smarrito, ma non smetterò di lottare pronunciando ogni notte il suo nome prima di dormire.
mauro
Posted at 08:02h, 12 AprileAlla prima lettura ero senza più parole da offrire alla seconda mi è solo uscito ” Questo scritto e'” :O) ti/vi abbraccio