
26 Apr 20 Un metro e quaranta
Questo racconto è stato pubblicato 2 anni fa, in un libro di Racconti dal Piemonte di un editore non particolarmente apprezzabile. Avevo pensato di inserirlo in una raccolta, ma questa probabilmente non vedrà mai la luce.
A volte la scrittura sa essere premonitrice, ma io tendo a non credere alle premonizioni, anzi, mi ero addirittura dimenticato di averlo scritto. A rileggerlo oggi, mi inquieta non poco.
Un metro e quaranta
“Ma che fa?! Mi lasci!”
Il cassiere si divincolò dall’abbraccio, minacciando, in sequenza, una chiamata ai Carabinieri, una denuncia per molestie e una morte subitanea e violenta. Infine spinse il presunto aggressore fuori dalla porta scorrevole, sul marciapiede gelato. Qualcuno dei clienti in fila alle casse assistette alla scena con stupore, qualcun altro con disappunto. Una signora urlò isterica, un tizio corpulento, sulla quarantina, si piantò sulla porta come se dovesse difendere la sua stessa casa. Venerando Altieri, con gli occhi sgranati di un pesce, si ritrovò in stato confusionale a guardarsi le braccia ancora protese. L’insegna del supermercato illuminava a giorno il sudore sulla sua fronte.
Non era la prima volta. Piccoli episodi analoghi avevano costellato quel cinquantunesimo anno della sua vita. A febbraio era stato licenziato dalla ditta di trasporti per cui faceva il contabile da undici anni. Rimosso per automatizzazione dell’organico, si era ritrovato come tanti in fila al centro per l’impiego. L’impiegata occhialuta e con i capelli di stoppa, residuato statale in estinzione, aveva gestito la sua pratica con ammirevole scortesia. Lui, per tutta risposta, sporgendosi di slancio sulla scrivania, le aveva stampato un bacio sulla guancia. Così, senza alcun preavviso nemmeno per se stesso. Mentre l’addetto alla security lo accompagnava alla porta spingendolo con la punta di un bastone, la signora faceva scivolare la pratica sotto una monumentale pila di scartoffie. Il timbro diceva “Soggetto a rischio”.
Al primo colloquio di lavoro, quattro mesi dopo quello spiacevole incidente, Venerando si era presentato ben pettinato, con un maglioncino blu e la cravatta, il curriculum fresco di stampa dentro una bustina trasparente, come si usava una volta. Tutto regolare, i convenevoli, le formalità, la cordialità. Il responsabile delle risorse umane lo aveva trattato con un garbo d’altri tempi, apprezzando la sua esperienza, i modi pacati, la puntigliosità e insieme la naturalezza con cui Venerando aveva risolto una prova di partita doppia.
“Non se ne trovano più molti come lei, al giorno d’oggi”, si era sbilanciato il responsabile, spiegandogli meglio la natura della mansione che avrebbe potuto ricoprire: controllo fatture e verifica dei calcoli automatizzati. Una formula elegante per dire che avrebbe dovuto fare da balia a un robot, per cinquecento euro al mese. L’uomo aveva sollevato la mano aperta, ammiccante, a mimare la cifra. E poi l’aveva agitata per congedarsi, alludendo a un arrivederci. Di fronte a quella mano tesa, Venerando non aveva esitato: battuto un cinque sonoro, aveva poi serrato il pugno per chiudere la sequenza. Senza avere il tempo di rendersene conto, aveva poi definitivamente smontato quella mezz’ora impeccabile accarezzando con delicatezza la guancia sbarbata e profumata dell’addetto. Il seguito era stato una ventina di secondi di silenzio e imbarazzo, e un le faremo sapere balbettato con terrore.
Dopo l’episodio del supermercato, e dietro opportuno sollecito dei Servizi Sociali, Venerando si decise a prendere appuntamento da uno psicologo. Prenotò online una visita da uno specialista comportamentale, il meglio recensito, sicuro che almeno lui sarebbe riuscito a spiegargli l’assurdità di quella condotta improvvisamente espansiva. Il medico, in verità, non fu molto gentile. Dopo avergli chiesto di raccontare due o tre cose sulla sua vita, lo liquidò distrattamente con la prescrizione riservata agli scemi: un po’ di riposo, le passeggiate al parco. “Si tratta di limitare il contatto umano allo stretto necessario, non c’è niente di meglio per combattere lo stress”, affermò con convinzione. Venerando si alzò dalla sedia più confuso di quando era entrato, tese istintivamente la mano verso il medico che gli restituì uno sguardo freddo e muto, che diceva chiaramente “Non si azzardi a toccarmi”.
Insoddisfazione. Ci mise un po’ a capirlo. Era questo il sentimento prevalente, nella testa di Venerando. E non solo nella testa, anche nei muscoli, nei nervi, fin dentro le ossa. Il corpo fremeva, smaniava, ardeva senza ulteriori spiegazioni. Le mani non volevano stare ferme, le imprigionò nelle tasche. Camminando verso casa, avvertì una sensazione insolita, faticava a trovarne traccia nei ricordi. Dev’essere questa la rabbia, pensò. Strinse i pugni dentro il cappotto, il pensiero lo spaventò, come lo spaventava quella sua specie di malattia che lo portava a toccare le persone come non aveva mai fatto, come non avrebbe dovuto. Da giovane aveva sempre scansato le manifestazioni eccessive, le effusioni, le urla. Non sopportava le pacche sulla spalla ai tempi della scuola. Già allora odiava essere toccato dai suoi interlocutori. Non era mai stato uno di quelli che correvano a lavarsi le mani dopo una stretta, ma aveva sempre preferito evitare, ad esempio, di accarezzare un cane. Un uomo nella norma, insomma, molto poco incline al contatto. Mai passionale, mai sopra le righe, lo sguardo basso e nessuna voglia di scambiare due chiacchiere con chicchessia. Adesso, in preda a quella irragionevole e inconsulta mania di prossimità, non si riconosceva più. “Deve ritrovare se stesso”, aveva detto il dottore. “Comprare un cellulare nuovo. Recuperare la giusta distanza dal prossimo, rinnovare il suo contratto sociale”. Bastava guardarsi intorno, ma con discrezione, per rintracciare negli altri la compostezza, il decoro, la serenità assicurata dal rispetto dello spazio altrui. Anche la legge, in questo senso, era chiara: lo spazio vitale di ciascun individuo era sacro e inviolabile, per un raggio di almeno centoquaranta centimetri. La violazione del confine era tollerata esclusivamente per i doveri coniugali, per un massimo di sei ore settimanali e un minimo di trenta minuti, e per la cura della prole e degli animali domestici, per le quali si prescriveva un limite unico di ventotto ore settimanali e un minimo di quindici. Non avendo mai avuto una moglie, un figlio o un gatto da fotografare, Venerando non aveva l’obbligo legale di indossare il braccialetto di monitoraggio familiare. Ma conosceva a memoria le norme, ne condivideva lo spirito. “L’individuo prima di tutto”, si ripeteva ossessivamente mentre attraversava piazza Castello. Attorno a lui decine di persone camminavano a capo chino su traiettorie indipendenti, per linee che non si incrociavano mai, se non per sporadico errore. Si fermò a osservarle meglio, si immaginò a scrutarle dall’alto, palline impazzite dentro un flipper. Più si soffermava a guardare, più le facce sembravano restituire, quando smettevano di fissare un display, occhiate di odio a tratti addirittura manifesto. Si mosse per evitare il richiamo di un Vigile per eccesso di sosta, seguì il consiglio del dottore, diresse i passi verso i Giardini Reali. Da troppo tempo non ci andava, pensò, mentre vedeva avvicinarsi le cime spoglie degli alberi. L’inverno era più clemente con gli arbusti e con le erbacce, osservò mentre calpestava il verde per andare a occupare una panchina. C’era un sole timido, e lui sperò che durasse per tutti i quindici minuti che gli erano concessi, prima che la panchina emettesse il segnale acustico anti-bivacco e si inclinasse per farlo sloggiare. Davanti a lui, a una cinquantina di metri di distanza, un uomo sulla settantina si muoveva in maniera insolita. Sembrava stesse borbottando, forse imprecando. Volgeva lo sguardo in tutte le direzioni, agitava il cellulare davanti alla faccia, pareva quasi che volesse lanciarlo. Si avvicinò con fare minaccioso.
“Ha visto un cane marrone?”, chiese bruscamente.
“No, mi dispiace”.
“Un boxer, non l’ha visto?”, insisté, ancora più stravolto, mimando l’altezza del suo cane con una mano.
“No, proprio, non l’ho visto. Ma non ha il chip? Non può localizzarlo col cellulare?”
“E secondo lei mi sarei avvicinato per chiederle? Si è scaricato, e le postazioni di carica non funzionano”.
Venerando avvertì un senso di fastidio, non provò alcun istinto di abbracciare quell’uomo, né di aiutarlo a cercare.
“Come si chiama il suo cane? Lo chiami ad alta voce, no?”, chiese svogliato.
“Mi prende in giro? Lo sa che non si può”.
“Le ripeto, mi dispiace. Adesso però la prego di lasciarmi in pace”, disse infine con durezza, e mentre quello si allontanava, una parte di lui si sentì un po’ in colpa. Per un attimo si fece spazio, tra pensieri contrastanti, l’idea bizzarra di alzarsi, di combattere il distacco che aveva mostrato qualche secondo prima e dare una mano. Forse avrebbe potuto essere più gentile, e il vecchio gliene sarebbe stato riconoscente, anche lui si sarebbe ammorbidito in un sorriso, magari avrebbero trovato il cane e poi si sarebbero salutati cordialmente, si sarebbero rivisti altre volte al parco. Arrestò il flusso stringendo i denti, mordendo un’imprecazione. Quel vecchio era stato sgarbato, che morisse dietro al suo cane. Lui sarebbe rimasto a godersi la sua panchina per i minuti che gli restavano. Ora si sentiva più fiero della sua fermezza, incrociò i piedi sul prato, allargò le braccia sullo schienale. Forse era questo che intendeva il dottore, questo il piacere della solitudine che doveva riconquistare. Poteva guarire, non avere pena del mondo. Si rallegrò e distolse lo sguardo dalla schiena del vecchio sempre più disperato.
Più in là, dietro una quercia, una signora impellicciata sembrava patire la stessa sorte. Vagava sul prato, chinandosi a cercare dietro le siepi, guardava lo schermo e allo stesso tempo badava a non sporcarsi le scarpe. Sussurrava, fischiava a un volume impercettibile. Per un attimo, i due padroni abbandonati incrociarono i loro sguardi, e a Venerando, senza che potesse opporsi, scoppiò in pancia un incontrollabile senso di speranza e di attesa. Li vide correre l’uno verso l’altro, stringersi e piangere, guancia a guancia, fino a mescolare le lacrime. Li vide inciampare e sporcarsi di fango, rialzarsi tenendosi per mano. Ma, riemergendo da quel secondo pacchiano e dorato della sua immaginazione, Venerando si rese conto che i due non si erano nemmeno rivolti la parola.
Ancora una volta, non sapeva se dirsi addolorato dalla realtà o deluso dalla sua debolezza, pensò che forse era il caso di prenotare un’altra seduta. Rassegnato, si alzò e si dispose a rincasare, quando sentì provenire un guaito sordo da un cespuglio dietro le sue spalle. Pensò si trattasse di un’altra allucinazione, scosse il capo e notò che il suono non cessava, non svaniva scrollando i pensieri. Con estrema cautela, si avvicinò agli arbusti, scostò i rami e li vide. Il boxer, ben piantato sulle zampe posteriori, si agitava grintoso sul dorso di uno splendido esemplare di levriero afgano. I due, la lingua penzoloni, sembravano sorridere, indisturbati.
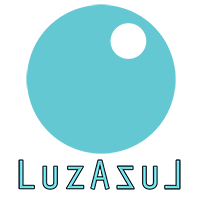
Sorry, the comment form is closed at this time.