
22 Apr 23 Parco giochi
“Perché, se lo spazio è il nostro, se lo devono prendere loro?”
“Loro” sono i grandi, l’autorità che irrompe in una radio scolastica. “Loro” sono anch’io, che non so oppormi a chi per mestiere occupa tutto lo spazio della parola, lo sottrae, blatera di giovani, presente e futuro. Ma non li ascolta praticamente mai. Io che, in fondo, come gli altri, mi riempio la bocca di buoni propositi sulla costruzione della libertà a partire dalla conquista della parola, la stessa libertà che però non riesco a portare oltre l’istituzionalità. Sono autorità anch’io.
Quella domanda sacrosanta mi gela, mi inchioda. Non so rispondere. Dico solo “hai ragione” a quel marmocchio, insopportabile per mille altri motivi, ma capace di una rivendicazione implacabile.
È lo stesso che in classe, qualche giorno dopo, ferma su Street View l’istantanea di una piazza tra le case popolari. Squallida, sbiadita e fuori fuoco sul grande schermo della LIM.
Uno scivolo, Un’altalena. Una panchina. E poi cemento, serrande intorno, verande di alluminio anodizzato, tende da sole, grate alle finestre.
Dura appena cinque minuti. Con il pennino il giovane del presente e del futuro traccia in maniera forsennata le linee del suo racconto tragicomico di un pomeriggio in questo scenario di quartiere. Un affresco confuso, a cavallo tra la realtà e l’iperbole, tra la testimonianza diretta e il sentito dire leggendario.
Racconta di un luogo in cui si può entrare in motorino solo impennando su una ruota, pena lo scherno, le botte o la diffidenza dei presenti. In fondo, sotto gli alberi storti, stanno i giovani spacciatori. Interagiscono in maniera confusa con le ragazze attorno all’altalena. Ridono, si guardano, si insultano, si chiamano urlando, si corteggiano. Un altro gruppo di ragazzi sta attorno allo scivolo. Qualcuno punta la stessa ragazza. Magari è la fidanzata, la sorella o la cugina di qualcun altro. Inevitabile la rissa, due stormi furiosi che si scontrano, si gonfiano, si disfano.
Il pennino forma e intreccia matasse sullo schermo: “Questi litigano con questi, minacciano questi altri, corrono a prendersi a calci”.
Alle finestre stanno le signore, quando serve qualcuna scende col bastone, a menare fendenti per riportare la calma. Le signore sono temute. Dietro le tende stanno gli uomini. “Qua sono tutti ai domiciliari”, dice. “Qualcuno ha il braccialetto. La droga, quella grossa, è qua dentro”, il pennino indica le palazzine.
E giù in strada i tratti di linee curve e veloci, uno sciame interminabile di scooter, un via vai di centauri a coppia, il vento sulle tempie rasate, perché il casco sarebbe marchio di intollerabile debolezza. Sgommano, si alzano sulla ruota posteriore, strombazzano, si sfidano.
Ogni tanto arriva la pattuglia, qualcuno sparisce alla vista, altri mantengono il presidio. Le dosi vengono nascoste con cura nelle intercapedini dello scivolo. Qualcuno si è attardato, ha violato la detenzione domiciliare, lo prendono in custodia, lo portano via. Urla, trambusto, sirene. Silenzio. poi la piazza si ripopola.
Il mio piccolo narratore racconta di un corteo funebre ripetuto per cinque giorni, la bara di un ragazzo morto in un incidente riportata in piazza per cinque volte, la strada bloccata, le volanti aggredite. Probabilmente questo è accaduto altrove e in altro modo, ma il racconto è fatto di confini imprecisi, ci tiene a fregiarsi di epica surreale.
– “E se nella piazza entro io, che succede?”, chiedo.
– “Due cose possono succedere, dipende dalla faccia. Ti squadrano. O sei della questura, o sei mandato”.
– “Mandato?”
– “Sì, mandato da qualcuno che ti ha detto dove comprare. Ma non devi sbagliare a parlare o a guardare. Non devi stare con lo sguardo basso, ma nemmeno fissare troppo a lungo”.
– “E tu, invece, dove stai?”
– “Io? Arrivo col mio motorino, lo parcheggio e mi siedo sulla panchina in fondo”
– “E che fai?”
– “Mi godo lo spettacolo”.
Uno spettatore, puro e divertito. Viene da un altro quartiere, con altre dinamiche probabilmente meno estreme, si siede con gli amici e guarda, ride, passa il pomeriggio intrattenendosi, affascinato da quei codici, da quell’umanità per me così lontana. Ha saputo conquistarsi un posto in prima fila, interagendo senza interferire. In qualche modo si è guadagnato quel lasciapassare tanto misterioso quanto solenne: il rispetto.
In quel contesto forse si sente grande, sente di stare lì dove le cose accadono, le cose importanti per la sua età, quelle che si possono raccontare e con cui darsi un tono.
O forse non ci è mai stato, si è inventato tutto, e sullo schermo, con una penna elettronica in mano, ha disegnato e intrecciato i racconti di qualcun altro, mescolati alla sua fantasia di dodicenne, al suo desiderio di avventura. Non so dirlo, e non mi importa, ma prima del suono della campanella gli chiedo che pensa di tutta la cocaina che, in quel teatro, vede passare.
“No, quella è porcheria, non mi interessa. Io da grande voglio fare il chirurgo”.
L’educatore avrebbe detto che è tutto sbagliato, che non sono posti da frequentare, che ci sono modi certamente migliori di passare i pomeriggi. Tutto giusto. Ma per oggi sono venuto meno al mio dovere istituzionale, cercando almeno di capire. Domani magari interverrò, giudicherò, ma oggi sono rimasto ad ascoltare. Anche solo per rispetto di quelle forme giocose, confuse, di mettere in scena personaggi e dettagli. Di quella spontanea e orgogliosa voglia di raccontare e basta. A me, che quella spontaneità tronfia la ammiro e un po’ la invidio. A me, che sono l’istituzione e metto i voti sul registro.
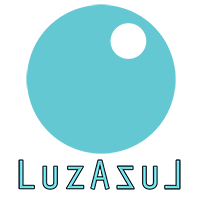
Sorry, the comment form is closed at this time.